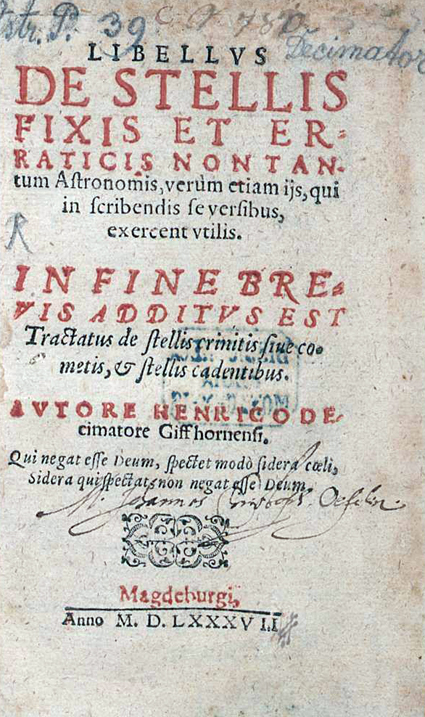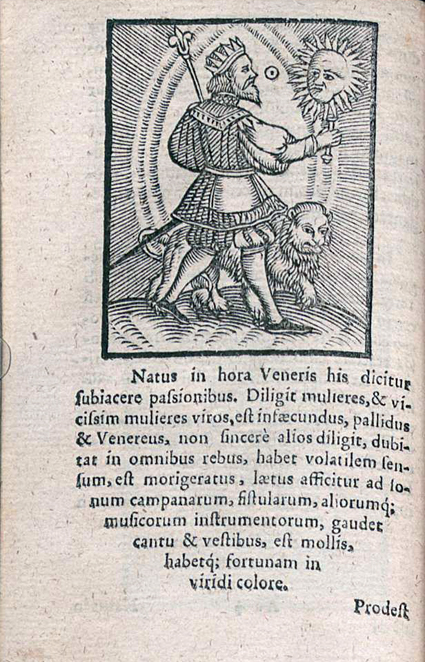|
Henricus
Decimator
Libellus
de stellis fixis et erraticis…in fine brevis additus est tractatus de
stellis crinitis sive cometis, et stellis cadentibus. Magdeburgum
1587
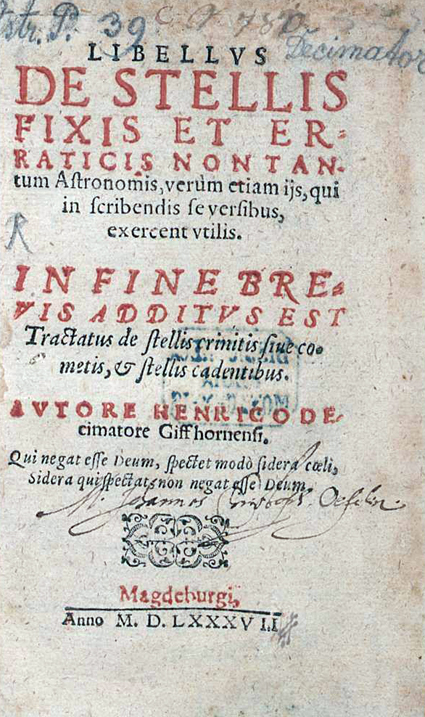
Henricus Decimator (1544-1615), teologo e umanista
tedesco di Gifhorn- Hanover, compone il libro che presentiamo con
l’intento di compendiare in una unica opera la descrizione del cielo
stellato, costellazione per costellazione, seguendo con precisione il
libro VIII dell’Almagesto di Tolomeo, completandolo con i vari
riferimenti filologici agli autori e studiosi che nei secoli successivi si
sono occupati , in modo scientifico o letterario, degli stessi argomenti.
Dopo aver dato nei primi capitoli le definizioni
principali quali quelle di Stellae,
De divisione Stellarum, De materia Stellarum, De figura Stellarum, De
Causa Scintillationi Stellarum…, l’autore si sofferma sulla
distinzione per genere delle figure celesti per poi elencarle
sommariamente. Segue finalmente la descrizione delle costellazioni
suddivise nelle tre classiche partizioni: De
Signis Zodiaci, De Signis Septentrionalibus, De Signis Austrinis.

La prima parte del trattato si conclude quindi con la
sezione dedicata alle stelle erranti o pianeti corredata da sette belle
incisioni allegoriche.
Una breve seconda parte del libro riassume le conoscenze
cinquecentesche relative alle comete e alle stelle cadenti.
Le
tesi sostenute dall'autore sono quelle classiche della filosofia
aristotelica scolastica sebbene un breve paragrafo dell'ultimo capitolo
sulle comete sia dedicato alle obiezioni che possono essere mosse all'idea
che questi corpi siano solo fenomeni atmosferici e non corpi celesti posti
oltre la Luna, tra le quali: Cometae moventur duplici moto iuxta motum
stellarum. Ergo: Sunt stellae. Vengono inoltre elencati esempi
di comete apparse nel cinquecento quali quelle del 1500, 1506, 1531, 1532,
1533, non è citata invece quella del 1577, la grande cometa per la quale
Tycho Brahe aveva calcolato un movimento in parallasse determinandone
quindi la sua sicura non appartenenza al mondo sublunare. Vedi a tal
proposito la sezione
Corpi
celesti
per
cortesia di
Museo
Astronomico - Orto Botanico di Brera
Università degli Studi di Milano
I disegni delle quarantotto figure tolemaiche, che
seguono sistematicamente la descrizione delle singole costellazioni, sono
prodotti ispirandosi genericamente allo stile dei planisferi del Dürer
del 1515
e sono quasi identiche a quelle prodotte da un anonimo autore
(Theodorus
Graminaeus)
per
illustrare l'opera
Arati
Solensis
PHAENOMENA ET PROGNOSTICA.
Interpretibus M. Tullio Cicerone, Rufo Festo Avieno, Germanico Caesare,
Una cum Eius Commentariis.
C.
Iulii Hygini Astronomicon...
Coloniae Agrippinae (
Cologne
) : apud Theodorum
Graminaeum, 1569 (1570).
Evidente anche
il riferimento all'opera di Vopel del 1534:
C. Ivlii Higini,
Avgvsti Liberti, Poeticon Astronomicon : Ad Vetervm exemplarium eorumq[ue]
manuscriptorum fidem diligentissime recognitum, & ab innumeris, quibus
scatebat, uitiis repurgatum, Coloniae 1534
http://www.atlascoelestis.com/Hyginusvopel%201534.htm
https://www.astronomie-nuernberg.de/index.php?category=duerer&page=decimator-1587
Le costellazioni sono rappresentate
in proiezione convessa come se fossero collocate sulla superficie
di un globo, sono però disegnate di spalle al fine di mantenere la
corrispondenza tra la posizione anatomica degli astri e la descrizione che
ne fa Tolomeo nel suo catalogo.
Le stelle,
suddivise in classi di sei magnitudini, sono riportate sulle carte insieme
al corrispondente indice numerico utilizzato nel catalogo
dell’Almagesto.
Con
un tratteggio viene indicata, nelle tavole dove è presente, la Via
Lattea, vedi ad esempio il Cygnus.
L’autore
indica con delle lettere latine le linee principali del reticolo di
riferimento utilizzato nelle singole tavole: il Tropico del Cancro e del
Capricorno, l’Equatore, l’Eclittica e le eventuali linee di
longitudine disegnate ogni 30 gradi.
Originale rispetto alle altre opere classiche scritte
sull’argomento sono le parti che Decimator aggiunge alla fine di ognuna
delle tre partizioni dove prende in esame e descrive
particolari del cielo stellato
non contemplati nell’Almagesto quasi ad anticipare il proliferare
di nuove costellazioni che si realizzerà a partire dal secolo successivo,
quali: De Praesepio sive Nubecula et
Asellis, De Corde Leonis, De Spica et Protigete, De Pleiadibus, De Propo,
De Urna, De Lineis et Nodo, De Berenices Crinis, De Arcturus, De Gorgoneis,
De Capra et Haedi, De Caduceo, De Aqua Aquarii….
Index
Huius Libelli

Confronta
l'opera di Decimator con il
De
le stelle fisse, Venezia 1540
di Alessandro Piccolomini
e
con il
Theatrum
mundi, et temporis,
Venezia
1588 di Giovanni Paolo Gallucci
|